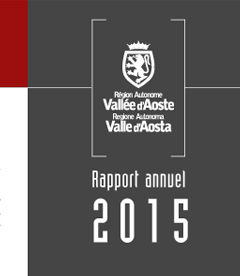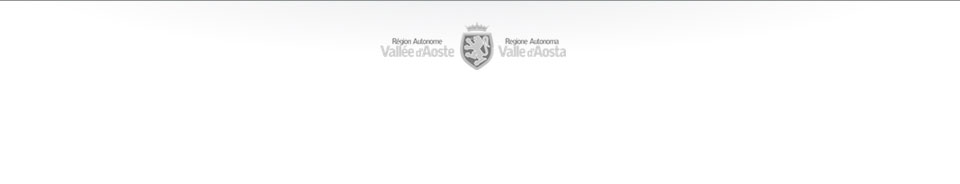La catalogazione dei beni culturali
La Struttura competente in materia di catalogazione controlla, aggiorna e implementa la schedatura dei beni culturali, presenti sul territorio regionale, raccogliendo nell’archivio informatizzato notizie e dati che le fonti edite via via restituiscono o che specifiche ricerche, svolte con la collaborazione di esperti nei diversi settori attinenti l’arte e l’architettura, rivelano.
L’implementazione del catalogo regionale dei beni culturali è progredita, inoltre, impostando e avviando il recupero delle nuove conoscenze emergenti dall’osservazione dei beni in occasione degli interventi di restauro. È evidente come l’opera, riportata a un buon grado di leggibilità attraverso il risanamento e il consolidamento del supporto, il fissaggio e la ricomposizione dei distacchi – si tratti di pellicola pittorica o di parti di una struttura lignea o muraria – nonché la pulitura dai sedimenti di sporcizia e da imprudenti ridipinture, con il ripristino della cromia originale e interventi di reintegrazione pittorica riconoscibili e reversibili, si ripresenti all’occhio dell’osservatore con rinnovata vitalità e capacità espressiva. Attraverso la lettura, la selezione e la classificazione dei dati e dei materiali contenuti nelle pratiche, numerose schede catalografiche e fotografiche già esistenti vengono integrate e altre ne vengono create. In molti casi si raccolgono, oltre alle informazioni sul lavoro di restauro o consolidamento effettuato, dettagli fisico-dimensionali precedentemente omessi o non completati in una compilazione ancora di semplice livello inventariale, descrizioni più circostanziate delle caratteristiche compositive del manufatto e dell’eventuale soggetto rappresentato, portando la scheda a un grado di completezza tale da venire definita di catalogo. Stampe cartacee in bianco e nero, diapositive, negativi su pellicola, cd e dvd originali trovano diversa e adeguata collocazione d’archivio, richiamata nella relativa schedatura. Di tutto ciò si varranno i fruitori dei documenti digitali così aggiornati
Reliquiario a cassetta. Aosta, Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta. Dopo il restauro (Robino Paolo) ![]()
Reliquiario a cassetta. Aosta, Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta. Pergamena miniata all'interno del castone anteriore del tetto. Dopo il restauro (Rosetta P.) ![]()
Statua raffigurante san Giovanni evangelista. Cogne, Chiesa parrocchiale di S. Orso. Durante il restauro (Cuaz Novella) ![]()
Sala della fenice, parete sud. Arnad, Castello Vallaise. Consolidamento dipinti murali (Gallarini Achille-Bonollo Maria Gabriella) ![]()
La Struttura gestisce inoltre la notevole quantità di fotografie, riguardanti beni storico artistici e architettonici, che nel corso del tempo è venuta a costituirsi e che, annualmente, aumenta mediante le campagne fotografiche di supporto delle attività di competenza della Soprintendenza per i beni e le attività culturali. In particolare nel 2015 sono stati avviati i lavori di ricerca, riordino, schedatura, condizionamento e imputazione dati nell’archivio alfanumerico di circa 2 mila 500 fotografie aventi per soggetto il castello di Sarre e i beni delle relative collezioni.
Collezioni Castello di Sarre. Dipinto raffigurante ritratto di Elena di Montenegro. ![]()
Collezioni Castello di Sarre. Scultura raffigurante militare a cavallo, di Giuseppe Norfini. ![]()
Collezioni Castello di Sarre. Dipinto raffigurante ritratto di Maria José del Belgio, di G. Brunello ![]()
Collezioni Castello di Sarre. Fotografia raffigurante Maria José del Belgio durante un'escursione sul Monte Rosa ![]()
Collezioni Castello di Sarre. Culla in legno. ![]()
Collezioni Castello di Sarre. Catino con decorazione centrale ad intrecci e lungo i bordi. ![]()
In attuazione delle convenzioni relative al censimento delle architetture di interesse storico artistico del secondo Novecento in Valle d’Aosta, stipulate tra la Regione, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e la Fondazione Courmayeur - Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia, le attività di ricerca hanno permesso la selezione provvisoria di circa 161 opere sulla base dei parametri bibliografici e storico-critici individuati dal MiBACT e di seguito riassunti:
1. L’opera è pubblicata in almeno due studi che si sono occupati sistematicamente dell’architettura moderna e contemporanea in Valle d’Aosta.
2. L’opera è pubblicata in uno degli studi precedenti e in una rivista di importanza internazionale italiana o straniera.
3. L’opera è pubblicata in almeno due riviste di importanza internazionale italiane o straniere.
4. L’opera riveste un ruolo significativo nel panorama dell’architettura della Valle d’Aosta negli anni in cui è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito che della ricerca architettonica internazionale.
5. L’opera riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere costruttivo;
6. L’opera è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura italiana o internazionale.
7. L’opera si segnala per particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano e ambientale in cui è realizzata.
Le tipologie di opere considerate sono varie, risultano selezionati: 20 edifici residenziali, 26 residenze di carattere turistico, 14 edifici per uffici, 8 infrastrutture, 17 edifici scolastici, 2 biblioteche, 2 edifici per servizi, 8 rifugi, 8 infrastrutture sportive, 10 edifici a carattere museale, 1 centro socio-assistenziale, 6 edifici di culto, 2 cimiteri, 8 edifici commerciali e per il terziario, 8 edifici industriali/produttivi, 3 hotel, 1 cinema, 7 aree archeologiche, 1 intervento di arredo urbano, 9 aree urbane. Sono stati inclusi nella selezione anche gli interventi su edifici storici, come ad esempio il castello di Ussel a Châtillon e la Torre dei Balivi ad Aosta, per la qualità architettonica delle parti nuove inserite nella preesistenza.
Questa prima ricognizione sulle opere da inserire nella selezione provvisoria permette già di fare alcune considerazioni critiche generali che possono aiutare nella scelta dei progetti da includere nella selezione definitiva, al fine di rendere il lavoro di schedatura finale il più possibile omogeneo e rappresentativo del panorama architettonico regionale. È infatti già possibile riconoscere alcune tendenze, geografie, culture architettoniche, scuole, linguaggi e tipologie ricorrenti che vanno a costituire, in momenti e luoghi differenti, i caratteri e l’identità dell’architettura moderna valdostana.
Le architetture di maggiore interesse, negli anni del boom edilizio degli anni cinquanta e sessanta, sono soprattutto opere legate alla residenza turistica (alberghi, complessi residenziali e seconde case) delle località del turismo alpino (Cervinia, Courmayeur, ecc.) a firma di autori di rilievo del panorama nazionale (Mollino, Albini, Fiore, Dolza, Derossi, Gabetti, Roggero, Oreglia d’Isola, ecc.).
Aosta, Condominio in Viale Conte Crotti, progetto di Carlo Mollino, 1951. ![]()
Quart, Monastero Carmelitane Scalze, progetto di Roberto Gabetti e Aimaro Isola con Guido Drocco, 1984-1986. ![]()
Valtournenche, Ostello Pirovano, progetto di Franco Albini con Luigi Colombini, 1948-1949. ![]()
Brusson, Colonia Montana Olivetti (ora centro socio-assistenziale), progetto di Claudio Conte e Leonardo Fiori, 1955-1961 ![]()