




De gustibus disputandum est
Riflessioni linguistiche a proposito di cibo e di gusti
Occuparsi di didattica della lingua all'interno di un percorso
dedicato al cibo significa aprire un numero di potenziali finestre
di approfondimento sul “sistema lingua” pressoché
infinito. Le specificità relative al dominio della cucina,
della gastronomia, dell'alimentazione offrono molteplici
occasioni di riflessione linguistica, a partire dall'osservazione delle
dinamiche conversazionali caratteristiche dei contesti comunicativi
conviviali: un gruppo di commensali seduti intorno a un tavolo utilizza
battute rituali codificate (ad esempio formule e routines di cortesia:
mi passi ***, per favore? Ne vuoi ancora? No, basta; Sì grazie;
di compiacimento: che bontà! È squisito!; di
chiusura: sono sazio, satollo, pieno, pieno come un uovo);
misura gli scambi di turno scandendo l'alternanza delle battute sul
ritmo della degustazione dei cibi; impiega con disinvoltura tecnicismi
esclusivi o per lo meno specifici di quell'ambito contestuale (leccarda,
schiumarola, trinciapollo) e tende a utilizzare - molto più
che in altre situazioni - parole che rispecchiano specifiche esperienze
linguistiche, sociali, culturali e geografiche. Pensiamo, ad esempio,
all'ambito dei geosinonimi, ovvero delle varianti lessicali impiegate
nelle varie aree della Penisola per fare riferimento a un medesimo referente.
A seconda della sede geografica, il grosso frutto estivo con scorza
verde e polpa rossa verrà denominato anguria (area settentrionale),
cocomero (area meridionale) o pasteca (alcune zone
della Liguria; cfr. fr. pastèque). In Toscana, per melone
si utilizzerà popone, e cacio per formaggio;
i cornetti, che alludono in centro Italia alle brioches
a forma di mezzaluna (croissants), saranno altrove i fagiolini
(che in Veneto sono chiamati tegolini) o, per influenza di
un noto marchio commerciale, coni gelato confezionati industrialmente.
Al sud Italia i maccheroni sottintenderanno genericamente qualsiasi
tipo di pasta alimentare, lunga o corta, forata o meno, mentre le costine
saranno considerate piccole bietole per frittate e ripieni soltanto
da parte di valdostani e piemontesi, corrispondendo a tagli di maiale
o agnello con l'osso in tutto il resto d'Italia. La selva di denominazioni
si fa particolarmente intricata quando ci si addentri nell'ambito delle
specificità relative, per esempio, alle preparazioni di carne
e verdure, ai tipi di pasta o ai formaggi. Emblematiche in questo senso
risultano le denominazioni dei prodotti da forno e delle varietà
di pane, differenti non soltanto da regione a regione, ma addirittura
tra località. Poche di esse, come grissini (dal piemontese
grissin o ghersin, diminutivo di ghersa “filone
di pane”), risultano convalidate a livello nazionale. Per biove,
micche (forse da una voce latina; cfr. fr. miche “pagnotta”
e, in area svizzera e belga, “panino”), micconi,
grisse, spaccate e rosette il dominio di
condivisione resta tutt'al più quello relativo all'Italia nord-occidentale.
 Della
marcatezza regionale di molte espressioni gastronomiche i parlanti -
adulti e bambini - sono spesso inconsapevoli, così come tendono
a non percepire, a meno di essere condotti a rifletterci, l'origine
dialettale di alcune denominazioni penetrate nell'italiano corrente.
È il caso dei piemontesi gianduia, bagna cauda
e vitello tonnato (vitel toné), dei liguri
trenetta, pesto, panissa; dei lombardi gorgonzola,
ossobuco, panettone, risotto; dei romaneschi
abbacchio, stracciatella e supplì;
dei napoletani pizza, mozzarella, sfogliatella,
babà; dei siciliani cannolo e cassata.
Della
marcatezza regionale di molte espressioni gastronomiche i parlanti -
adulti e bambini - sono spesso inconsapevoli, così come tendono
a non percepire, a meno di essere condotti a rifletterci, l'origine
dialettale di alcune denominazioni penetrate nell'italiano corrente.
È il caso dei piemontesi gianduia, bagna cauda
e vitello tonnato (vitel toné), dei liguri
trenetta, pesto, panissa; dei lombardi gorgonzola,
ossobuco, panettone, risotto; dei romaneschi
abbacchio, stracciatella e supplì;
dei napoletani pizza, mozzarella, sfogliatella,
babà; dei siciliani cannolo e cassata.
E, d'altra parte, i nomi di alimenti e pietanze possono avventurarsi
anche molto oltre i confini di una lingua o nazione. Se è vero
che di termini (e dei relativi referenti) come pizza e spaghetti
ci è debitrice gran parte del mondo occidentale, è
altrettanto vero che anche l'italiano nel corso dei secoli ha attinto
a piene mani da altri idiomi e culture. Abbiamo, così, forestierismi
gastronomici integrati in tempi così lontani da non essere più
certamente percepiti come tali: alla dominazione araba nel bacino del
Mediterraneo risalgono, per esempio, voci come carciofo, melanzana,
zucchero e caffè; agli storici contatti con
la Francia entrate adattate come cotoletta e filetto,
e altre conservate in veste esotizzante come bignè (fr.
beignet derivato di buigne “bernoccolo”),
entrecôte e vol-au-vent; alla veicolazione dell'olandese
prestiti come baccalà, stoccafisso, pompelmo
(dal tamil pampalimasu); all'influsso dell'inglese tipi come
punch e roastbeef, oltre all'apparentemente nostrano
bistecca (beef-steak, composto di beef “bue”
e steak “fetta di carne”) e ai più recenti
hamburger (tratto dalla locuzione Hamburger steak
“bistecca amburghese”) e ketchup. Esempi di prestiti
di necessità, ovvero di importazioni sincrone di referente e
significante, sono rappresentati dal turco yogurt, dall'ungherese
gulasch, dal russo vodka o da esotismi introdotti
attraverso mode o occasioni di contatto linguistico più recenti
(giapp. sushi e surimi; sp. tapas; ar. cuscus).
I viaggi delle parole non si limitano, però, a superare i confini
politici e geografici; sfidano anche quelli grammaticali, osando passaggi
di status - da nome proprio a nome comune (besciamella, prestito
adattato dal francese béchamel, dal cognome del cuoco
Louis de Béchamel, inventore della salsa nel XVII secolo; gorgonzola,
dal toponimo della cittadina lombarda) - o di consistenza e significato.
È il caso dei numerosi termini gastronomici entrati nell'uso
con accezioni traslate o metaforiche: di un individuo noioso o seccante
si dice che è una pizza, di uno ottuso o insignificante
che è una rapa o un baccalà, di uno
privo di vigore fisico o morale che è una mozzarella,
di un altro eccessivamente magro che è uno spaghetto,
di uno di indole mite che è un pezzo di pane. Una persona
con presa malsicura ha le mani di pasta frolla; chi mescola
impropriamente elementi eterogenei fa una macedonia e chi combina
un guaio o un pasticcio una frittata. Pur senza fare riferimento
a riti cannibali, è possibile cucinarsi una persona (“adesso
me lo cucino per bene”), arrostirsi al sole, cuocere
nel proprio brodo o in un brodo di giuggiole, essere divorati
dall'invidia, bollire di rabbia, stufarsi, stufare,
friggere per l'impazienza e eventualmente mandare a farsi
friggere qualcun altro.
Le possibilità di esplorazione linguistica offerte dal tema del
cibo, insomma, sono particolarmente stuzzicanti e appetitose.
I percorsi che andiamo a proporre prendono in considerazione, pur sotto
differenti aspetti, soltanto una porzione del potenziale linguistico
offerto dal dominio: quella legata al lessema gusto. Si tratta
di una sintesi di esperienze compiute da un gruppo di studenti del corso
di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università
della Valle d'Aosta frequentanti il corso e il laboratorio di Didattica
della lingua italiana condotti da chi scrive nell'anno accademico
2004/2005. Gli studenti, futuri insegnanti di scuola dell'infanzia e
elementare, sono stati sollecitati a produrre riflessioni e proposte
didattiche a partire dal tema-stimolo. Le idee si sono moltiplicate,
ispirando molti e variegati percorsi che sono stati poi sperimentati
in differenti scuole, dove sono stati accolti con curiosità e
entusiasmo da bambini e insegnanti.
Ciò che qui presentiamo è una sorta di rassegna delle
esperienze più significative, rassegna necessariamente schematica
e stringata, e che tuttavia speriamo possa risultare utile per la progettazione
di analoghe esperienze, da graduare e variare nella loro realizzazione
a seconda del livello di scuola e, naturalmente, sulla base di interessi,
competenze e bisogni dei giovani interlocutori.
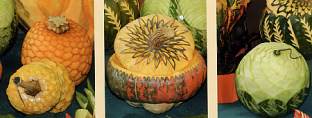
De gustibus disputandum est
I gusti, questo è pacifico, non si discutono, ma a proposito di gusti e di gusto si può discutere - parlare, ragionare, dibattere - per occuparsi di educazione linguistica. Questo, per lo meno, è quanto si è proposto di dimostrare il gruppo di studenti cui è stato chiesto di elaborare e sperimentare alcune proposte didattiche ispirate al tema del gusto. L'idea di partenza è stata quella di raccogliere curiosità e interrogativi intorno al lessema, per poi immaginare approfondimenti relativi a aspetti differenti della didattica della lingua madre. Il primo quesito, solo apparentemente semplice o anche banale, ha riguardato gli aspetti semantici del termine (§: I significati di gusto). Poiché le differenti accezioni sono risultate essere in stretta relazione con l'origine e la storia della parola, l'interesse si è poi indirizzato da un lato verso il settore onomasiologico, ovvero in direzione di un confronto con i termini impiegati in altre lingue e culture per esprimere il medesimo significato (§: La storia del gusto), d'altro lato verso gli aspetti pragmatici, legati alla collocazione e agli usi concreti della parola all'interno dell'italiano contemporaneo (§: La famiglia del gusto). In quest'ambito ci si è domandati con quale frequenza la parola “gusto” ed altre parole ad essa connesse vengano utilizzate (§: La frequenza del gusto) e in combinazione con quali termini e gesti nello specifico della produzione infantile (§: I gesti del gusto).
I significati di gusto
Che cosa intendiamo quando parliamo di gusto? Il gusto
può essere, innanzitutto, il senso che permette di percepire
e distinguere i sapori, ma anche, per estensione, il sapore stesso (per
esempio “una caramella al gusto di limone” o “una
caramella senza gusto”). Sempre per estensione, con gusto
si può fare riferimento al piacere che si prova mangiando e bevendo
(“mangiare con gusto”, “bere di gusto”),
ma non soltanto. In senso figurato, infatti, è possibile ridere
di gusto, prendere gusto a un'azione che si presumeva
indifferente o fastidiosa e fare il gusto a attività
inconsuete. Appagamento e piacere possono essere espressi in senso metaforico
(“ci provo gusto”) o antifrastico, quando si intenda
mettere ironicamente in discussione la presunta piacevolezza di un'esperienza
o attività (“sai che gusto!”). L'idea della
soddisfazione accompagna anche l'idea di gusto come voglia
o capriccio (“mi sono preso / tolto il gusto di dire
quello che pensavo”), preludio all'identificazione di gusto
con quel senso estetico che consente di distinguere ciò che è
bello e raffinato (“una scelta di gusto”, “una
persona di buon gusto”) da ciò che risulta volgare,
privo di delicatezza, inopportuno (“cattivo gusto”,
“dubbio gusto”). Ancora, gusto può
alludere allo stile condiviso da un'epoca e un ambiente (“gusto
liberty”) o, soprattutto se flesso al plurale, a inclinazioni,
preferenze e percezioni del tutto soggettive e personali (“non
è di mio gusto”, “è questione di
gusti”). Il plurale gusti, d'altra parte, viene
anche più prosaicamente utilizzato in riferimento alle erbe aromatiche
utilizzate in cucina per insaporire le vivande (“cucinare l'arrosto
con i gusti”).
Ci troviamo, dunque, di fronte a un sostantivo polisemico, a proposito
del quale - per lo meno di fronte a parlanti ancora acerbi - non ci
si può accontentare della frettolosa domanda di rito “sapete
che cosa vuol dire?”. Per verificare e rafforzare i livelli di
consapevolezza di questa sua ricchezza semantica in bambini di età
diverse, alcuni gruppi di studenti hanno elaborato differenti tecniche
di elicitazione e rafforzamento degli aspetti della competenza lessicale
ricettiva e produttiva. Presentiamo qui la scheda di sintesi relativa
ad alcune delle attività volte a verificare quanti e quali accezioni
del termine gusto risultassero effettivamente accessibili ai
giovani parlanti, ed altre finalizzate alla rilevazione delle competenze
semantiche ricettive e produttive preesistenti ai fini di un loro potenziamento.
DA PASSIVO A ATTIVO: SCORCIATOIE DEL
LESSICO Antonia Malara, Stefania Mastroianni, Monica Romeo, Loredana Rossi, Antonella Sorace |
Premesse
Il patrimonio lessicale di ciascun parlante comprende una parte di vocabolario costituito da parole che usa normalmente, in modo più o meno pertinente (lessico attivo o produttivo), e da una parte, molto più consistente, comprensiva invece di termini che solitamente non utilizza, ma di cui è in grado di comprendere, almeno in parte, il significato (lessico passivo). La didattica del lessico di stampo tradizionale focalizzava la propria attenzione sul lessico attivo, proponendosi di aumentare il numero di parole utilizzate da un parlante senza, però, tenere conto di numerosi aspetti legati all'uso linguistico in situazione (In quali contesti può essere utilizzata la parola? Con quali altre parole entra solitamente in combinazione? In quali parti può essere scomposta?…). La competenza lessicale di un parlante può invece essere più opportunamente rinforzata sulla base del potenziale racchiuso nel serbatoio del lessico passivo, attraverso interventi finalizzati a fornire più precise informazioni semantiche, ma anche fonetiche, morfo-sintattiche, pragma-linguistiche, ecc. che mirino innanzitutto a un potenziamento qualitativo che doti il parlante, oltre che di significati, di concrete possibilità d'impiego dei nuovi lessemi. In ambito scolastico, tale processo può essere favorito da uno stretto ancoraggio delle proposte di educazione lessicale al mondo delle esperienze infantili, ovvero da un approccio metodologico di ricerca 'ambientale' che stimoli spontaneamente il bisogno di approfondimenti semantici pregnanti e motivanti rispetto a concetti, oggetti, eventi già noti. È quello che abbiamo verificato durante la conduzione del lavoro che non ha privilegiato il solo aspetto quantitativo dell'arricchimento lessicale, ma su sollecitazione degli stessi bambini si è aperto alla prospettiva qualitativa, favorendo così l'adozione di un metodo di lavoro più aderente agli interessi degli apprendenti e quindi più motivante. La ricerca di nuovi vocaboli e la comprensione di nuovi significati sono avvenute a partire da “bisogni linguistici” concreti, attraverso una costante negoziazione e rinegoziazione dei significati già posseduti e il sistematico confronto tra pari. Grazie a questa attività i bambini hanno avuto modo di approfondire la conoscenza semantica di numerosi termini legati al concetto di “gusto” già presenti nel loro lessico potenziale, ma non ancora inseriti nel dominio del loro lessico attivo, e quindi non utilizzabili. L'attività
|
ATTIVITÀ DI ELICITAZIONE NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA Daniela Belley, Manuela Dalle, Deborah Dayné, Silvia Ducourtil, Katya Foletto, Alessandra Genova, Federica Giunta |
Per verificare quali associazioni di significato
vengano compiute in età infantile relativamente al termine
“gusto”, è stata elaborata e somministrata
a un gruppo di bambini di 5 anni una breve intervista. Le risposte
ad alcune delle domande, proposte individualmente, hanno evidenziato
come il termine singolare “gusto” venga prevalentemente
associato al significato di sapore alimentare (alla domanda
“se dico la parola ‘gusto’, che cosa ti viene
in mente?” undici bambini su venti hanno elencato i cibi
preferiti) mentre il plurale “gusti” (“quali
sono i tuoi gusti?”) evochi più genericamente significati
riferiti a preferenze e inclinazioni personali di ambiti diversi
(giocare, colorare, disegnare, ecc.). |
La storia del gusto
Il termine italiano gùsto deriva dal latino GUSTUM
(GUSTUS, ÛS)(2), di origine indoeuropea(3) (cfr. gotico
kustus, greco gêusis). Un confronto tra le due forme consente
di individuare con immediatezza i fenomeni di caduta della consonante
finale, che in latino svolgeva funzioni morfologiche perdute nell'italiano,
e la riduzione di -U finale ad -o. Solo apparentemente usuale è,
invece, la conservazione della U tonica, che nel passaggio dal latino
all'italiano si sarebbe dovuta ridurre ad ó (cfr. ad esempio
NUCEM > nóce, CRUCEM > cróce,
GULAM > góla)(4). La conservazione della
vocale latina si spiega, in effetti, per analogia con la forma verbale
GUSTARE, ricavata dal sostantivo, che ha continuatori, oltre che nell'italiano
e nei suoi dialetti, in spagnolo (gustar), francese (goûter,
e francese medievale goster-gouster), rumeno (gustare)
e in numerosi altri idiomi d'area romanza.
Questo rapidissimo excursus storico-linguistico ci serve per
introdurre una proposta relativa all'inserimento in classe dell'osservazione
comparata di forme etimologiche e forme derivate in italiano e nelle
altre lingue di studio. Esplorare, confrontare, individuare analogie
e differenze tra strutture della lingua madre e esiti presenti nelle
lingue straniere - se fatto a livelli di approfondimento commisurati
alle reali potenzialità degli apprendenti - conduce, infatti,
non soltanto a percepire in modo meno superficiale le caratteristiche
della propria lingua, ma anche a distinguere ciò che è
generale nell'organizzazione linguistica da ciò che è
specifico di un particolare codice. La formulazione di generalizzazioni
e ipotesi sul funzionamento di idiomi differenti porta gradualmente
allo sviluppo di strategie capaci di attivare il trasferimento di processi
cognitivi, conoscenze, esperienze ed abilità da una lingua all'altra,
favorendo l'apprendimento ricettivo, quando non produttivo, di più
idiomi. In questa direzione vanno le indicazioni del Consiglio d'Europa,
che anche attraverso il Quadro comune europeo di riferimento per
le lingue individua nella promozione dell'intercomprensione o comprensione
multilingue una delle soluzioni strategicamente più efficaci
per il superamento delle situazioni di monolinguismo. E in questa dimensione
si inscrive la proposta elaborata dalle studentesse Antonella Jacquin
e Lea Zoja, già docenti di lingua inglese nella scuola elementare.
Presentiamo qui di seguito una scheda di sintesi delle attività
da loro ideate e sperimentate con bambini di 6-8 anni nell'ambito di
un percorso a proposito dei “gusti” alimentari.
CONFRONTI INTERLINGUISTICI E INTERCOMPRENSIONE Antonella Jacquin, Lea Zoja |
|
Premesse
Imparare una lingua, oggi, non è un fatto puramente strumentale, ma è anche un fatto culturale e di sensibilizzazione estetica e morale; è per questo che l'insegnante deve tener conto dell'ambito in cui opera al fine di stimolare una riflessione sulla realtà linguistica contestuale ed arricchirla con l'apporto di altre realtà con le quali il bambino entra in contatto. L'apprendimento di più lingue, in effetti, avvalendosi di approcci metodologici coordinati mobilita processi di integrazione, rafforza lo sviluppo cognitivo e facilita l'interazione culturale. Adottando un punto di vista storico-linguistico e comparativo, è possibile affrontare la didattica delle lingue, per esempio, attraverso il confronto di semplici frasi e termini nelle tre lingue insegnate nella scuola primaria (italiano, francese, inglese). L'affinità sarà di norma più marcata tra le lingue romanze (italiano e francese), in quanto entrambe derivate dal latino parlato, rispetto all'inglese, tuttavia se opportunamente guidati anche nella fascia di età della scuola elementare gli alunni saranno in grado di operare confronti di natura fonetica, grafica e anche morfo-sintattica nei confronti di idiomi anche tipologicamente molto distanti. L'attività |

Parentele del gusto
Ogni lingua accresce costantemente il proprio patrimonio lessicale
creando parole a partire da basi già esistenti. La consapevolezza
dei meccanismi che governano tali processi (prefissazione, suffissazione,
composizione) permette non solo di cogliere la struttura delle parole
conosciute, ma anche di intuire il significato di quelle che si incontrano
per la prima volta. Di questo sono ben consapevoli i pubblicitari, che,
per catturare l'attenzione del pubblico moltiplicando il valore elativo
delle espressioni, sfruttano spesso le potenzialità derivative
della lingua per coniare espressioni non convalidate dall'uso ma facilmente
decifrabili.
È il caso, tanto per rimanere nell'ambito dei “gusti”
alimentari, di coniazioni trasparenti come extra-gusto (di
una gomma da masticare), scioglievolezza (di un cioccolatino),
frescosità (di una caramella alla menta), sciropposità
(di un succo di frutta), croccantezza (di un cracker), ecc.
I bambini, anche quando inconsapevoli dei processi che regolano tali
formazioni, sono tuttavia in grado di decodificarne il significato analizzandone
la struttura alla luce delle coordinate interlinguistiche che li stanno
sostenendo nel perfezionamento acquisizionale dell'italiano. Non per
nulla, utilizzano solitamente il lessico potenziale di una
lingua in modo assai più libero di quanto facciano gli adulti,
come dimostrano le formazioni creative che compaiono diffusamente nelle
loro produzioni orali e scritte.
PARADIGMI DERIVAZIONALI |
||||||||||||
Una volta costruito il modello derivazionale,
è possibile:
|
Per condurre i bambini a riflettere sui meccanismi relativi alla suffissazione,
è possibile proporre loro varie attività di manipolazione
delle parole, che conducano all'individuazione di paradigmi derivazionali
costanti e rappresentativi di fenomeni morfologici, come il passaggio
di categoria grammaticale.
Un ulteriore stimolo attraverso il quale i giovani parlanti vanno guidati
nella scoperta di come una lingua possa autoalimentare il proprio serbatoio
lessicale riguarda i meccanismi di attribuzione di nuovi significati
a voci già esistenti. Similitudini e metafore entrano, in effetti,
molto spesso a far parte di combinazioni fisse di parole - locuzioni,
espressioni polirematiche, modi di dire - il cui significato rischia
di essere colto in modo indistinto e impreciso.
Con l'obiettivo di offrire loro le chiavi necessarie per dischiudere
l'universo degli usi figurati del “gusto”, Arline Menghi
e Simon Jeantet hanno proposto a quindici allievi di una classe quinta
della scuola elementare di Gignod una serie di percorsi di semantica,
di cui qui presentiamo i risultati.
LA RICERCA DEI SIGNIFICATI Arline Menghi, Simon Jeantet |
|
L'attività è nata dalla necessità di
verificare se i bambini avessero coscienza delle diverse accezioni
e possibilità d'uso che una parola possiede, non soltanto
quando viene considerata isolatamente, ma soprattutto quando entra
in combinazione con altre parole e contesti differenti. Tenendo
presenti tutti gli aspetti considerati fondamentali per la valutazione
della conoscenza pragmatica di un termine, abbiamo strutturato
un repertorio di accezioni e modi di dire contenenti i termini
gusto, dolce, salato, amaro, aspro. A partire da questo, abbiamo
predisposto un test di riconoscimento dei significati letterali
e figurati all'interno di frasi campione da proporre ai bambini
(ad es. dolce: un pescatore d'acqua dolce; sento una dolce melodia;
questo è un ricordo dolceamaro; casa, dolce casa; il dolce
far niente, ecc.). Successiva-
mente allo svolgimento della prova, che ci ha consentito di stimare i livelli di competenza lessicale sotto il profilo passivo, abbiamo proceduto a indagare la consapevolezza semantica attiva dei bambini chiedendo loro di fornirci una definizione dei cinque lemmi citati. Com'è noto, la capacità definitoria è un'abilità molto raffinata, che interviene soltanto ad un certo stadio di maturità linguistica. Non ci ha quindi stupiti il fatto che per spiegare il significato delle parole i bambini abbiano spesso fatto ricorso a esempi concreti (dolce è un pasticcino; aspro è come il limone), tautologie (dolce è una cosa dolce, con lo zucchero), sinonimie (aspro è acido) e antonimie (amaro è il contrario di dolce). Non sono mancati, tuttavia, tentativi di definizione maggiormente orientati alla spiegazione descrittiva dei significati (gusto è una cosa che si sente in bocca quando mangi), che però soltanto in casi isolati ha compreso anche i significati metaforici (dolce è qualcosa di piacevole e calmo, gentile). Poiché entrambe le sperimentazioni hanno messo in luce la tendenza dei bambini a ricondurre e confinare i termini gusto, dolce, salato, amaro, aspro ai loro significati concreti, letterali e “alimentari”, il percorso è proseguito con un'ulteriore serie di stimoli (ricerca dei termini sui dizionari; raccolte di modi di dire; associazione di un sapore a un colore, a uno stato d'animo, ecc.) destinati a condurli gradualmente verso una maggiore disponibilità agli usi polisemici e astratti del linguaggio figurato. Riferimenti bibliografici |
La frequenza del gusto
 I
più ampi e aggiornati dizionari oggi disponibili per la lingua
italiana contengono più di duecentomila voci, corrispondenti
ai lemmi cui i più di due milioni di forme esistenti
possono essere ricondotti (gustavi, gustammo, gusterete…?
gustare; gustosa, gustose, gustosi? gustoso). Se è vero
che nessun parlante - per quanto erudito - conosce e utilizza realmente
una simile quantità di parole, è altrettanto vero che
la scuola deve proporsi di condurre tutti i parlanti a conoscere e utilizzare
almeno una quantità di esse sufficiente a comunicare in modo
sicuro e efficace. Sulla base di complesse ricerche svolte dal linguista
Tullio De Mauro e dalla sua équipe di collaboratori, tale quantità
può essere in primis identificata nel cosiddetto vocabolario
di base, vale a dire in un insieme di circa 7 000 lemmi, a frequenza
altissima, che costituiscono da soli il 90% di tutto ciò che
viene detto, scritto o letto. A una buona conoscenza del vocabolario
di base è auspicabile, poi, che con il procedere del percorso
di alfabetizzazione si accompagni un uso pertinente dei termini appartenenti
al cosiddetto vocabolario comune, comprensivo di altri 45 000
lemmi mediamente compresi e utilizzati da chiunque abbia un grado di
istruzione medio-alto. Sulla base di questi presupposti, nell'ultimo
decennio sono stati pubblicati alcuni dizionari caratteristici per la
presenza, a fianco della glossa relativa a ciascun lemma, della “marca
d'uso” che ne indica il livello e l'ambito di diffusione. Dal
più importante di questi, il Grande dizionario italiano dell'uso
diretto da T. De Mauro (Torino, Utet, 1999: 260 000 lemmi), sono
stati ricavate edizioni ridotte per l'infanzia, all'interno delle quali
il codice relativo alla marca d'uso è sostituito da simboli accessibili
anche ai più giovani. Facendo riferimento a questi strumenti,
e riconducendosi alla metodologia sviluppata nell'ambito delle ricerche
sui lessici di frequenza, un gruppo di studentesse ha elaborato un percorso
di rilevazione dei dati statistici relativi agli usi lessicali in bambini
di 6-7 anni, per procedere poi a ideare attività di potenziamento
e rafforzamento della produzione.
I
più ampi e aggiornati dizionari oggi disponibili per la lingua
italiana contengono più di duecentomila voci, corrispondenti
ai lemmi cui i più di due milioni di forme esistenti
possono essere ricondotti (gustavi, gustammo, gusterete…?
gustare; gustosa, gustose, gustosi? gustoso). Se è vero
che nessun parlante - per quanto erudito - conosce e utilizza realmente
una simile quantità di parole, è altrettanto vero che
la scuola deve proporsi di condurre tutti i parlanti a conoscere e utilizzare
almeno una quantità di esse sufficiente a comunicare in modo
sicuro e efficace. Sulla base di complesse ricerche svolte dal linguista
Tullio De Mauro e dalla sua équipe di collaboratori, tale quantità
può essere in primis identificata nel cosiddetto vocabolario
di base, vale a dire in un insieme di circa 7 000 lemmi, a frequenza
altissima, che costituiscono da soli il 90% di tutto ciò che
viene detto, scritto o letto. A una buona conoscenza del vocabolario
di base è auspicabile, poi, che con il procedere del percorso
di alfabetizzazione si accompagni un uso pertinente dei termini appartenenti
al cosiddetto vocabolario comune, comprensivo di altri 45 000
lemmi mediamente compresi e utilizzati da chiunque abbia un grado di
istruzione medio-alto. Sulla base di questi presupposti, nell'ultimo
decennio sono stati pubblicati alcuni dizionari caratteristici per la
presenza, a fianco della glossa relativa a ciascun lemma, della “marca
d'uso” che ne indica il livello e l'ambito di diffusione. Dal
più importante di questi, il Grande dizionario italiano dell'uso
diretto da T. De Mauro (Torino, Utet, 1999: 260 000 lemmi), sono
stati ricavate edizioni ridotte per l'infanzia, all'interno delle quali
il codice relativo alla marca d'uso è sostituito da simboli accessibili
anche ai più giovani. Facendo riferimento a questi strumenti,
e riconducendosi alla metodologia sviluppata nell'ambito delle ricerche
sui lessici di frequenza, un gruppo di studentesse ha elaborato un percorso
di rilevazione dei dati statistici relativi agli usi lessicali in bambini
di 6-7 anni, per procedere poi a ideare attività di potenziamento
e rafforzamento della produzione.
STATISTICA DEL GUSTO Cristina Amato, Carla Berlier, Tiziana Bois, Romina Costaz, Sara Peller, Mariagrazia Tedesco, Maria Grazia Tetto |
Premesse
Lo sviluppo semantico e lessicale è forse l'aspetto della competenza linguistica sul quale la scuola primaria ha maggiori possibilità d'intervento. Benché il processo di acquisizione lessicale segua itinerari non lineari, legati alle esperienze che il bambino compie sin dai primi anni di vita e ai modelli offerti dai parlanti dell'ambiente circostante, intervenire con precocità e sistematicità sulle potenzialità ancora inutilizzate dal bambino significa consentirgli di superare punti di arresto che condizionerebbero altrimenti tutti i suoi apprendimenti futuri. Più le capacità intellettive riescono a svincolarsi dall'aspetto percettivo delle cose, cogliendo le relazioni possibili tra i dati dell'esperienza, più il lessico si articola e si arricchisce di vocaboli anche astratti e dei relativi significati. L'attività Riferimenti bibliografici Dizionari |
I gesti del gusto
Il linguaggio gestuale, a lungo trascurato dagli studiosi di linguistica,
è stato tradizionalmente oggetto di grande interesse da parte
di differenti settori della ricerca semiologia, psicologica e socio-antropologica,
che ne hanno messo in evidenza le valenze simboliche e la complessità
culturale. È soltanto a partire dagli anni Ottanta che le potenzialità
della competenza gestuale hanno cominciato ad essere prese in considerazione
anche come strumenti dell'educazione linguistica per il consolidamento
delle abilità comunicative. Una buona conoscenza del significato
dei gesti, del registro cui appartengono, delle espressioni verbali
cui corrispondono può, in effetti, aiutare a sviluppare migliori
capacità di ricezione e interpretazione dei messaggi e a raffinare
la produzione del parlante, soprattutto quando questi debba sopperire
a carenze del linguaggio verbale, come nel caso di parlanti stranieri
o persone afasiche.
Come è noto, i bambini sperimentano in genere il linguaggio gestuale
molto prima di quello verbale: aprire e chiudere la mano in segno di
saluto, mettere l'indice davanti alla bocca per invitare a fare silenzio,
battere le mani, scuotere la testa per rifiutare… sono routines
che anche i più giovani riescono molto in fretta a decodificare,
e che in genere amano riprodurre. A questi - convenzionali, socialmente
codificati e espliciti - si affiancano gesti eseguiti senza che il soggetto
abbia l'intenzione e la volontà di trasmettere una certa informazione.
Si tratta, per lo più, di espressioni del viso o posture del
corpo assunte inconsapevolmente, che possono rivestire all'interno di
un'interazione un ruolo anche più significativo di quello rappresentato
dalle parole e dai ruoli degli interlocutori. All'osservazione dell'una
e all'altra tipologia di gesti ha dedicato l'attività di sperimentazione
un gruppo di studentesse che si proponeva di individuare i comportamenti
non verbali riscontrabili in un gruppo di bambini fra i 3 e i 5 anni
sollecitati a esprimersi a proposito dei gusti alimentari,
dominio indubbiamente significativo per i giovani parlanti sia sotto
il profilo affettivo che sotto quello esperienziale.
PROVA DI DEGUSTAZIONE Daniela Belley, Manuela Dalle, Deborah Dayné, Silvia Ducourtil, Katya Foletto, Alessandra Genova, Federica Giunta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'attività proposta ai bambini, consistente in una prova
di degustazione individuale di alimenti e bevande, è
stata integralmente videoregistrata. Questo ha consentito la
successiva analisi delle produzioni verbali e gestuali. Relativamente
a quest'ultimo aspetto, si è provveduto a catalogare
e etichettare i diversi gesti registrati per ricondurli all'atto
comunicativo di riferimento. Per ciascun gesto sono stati
Riferimenti bibliografici |

Conclusioni: per un'educazione linguistica riflessiva
La rassegna di proposte qui presentata si propone di essere esemplificativa
di una modalità didattica che tenga conto, in primo luogo, delle
varietà e potenzialità della lingua con l'obiettivo di
rendere consapevoli gli apprendenti di come essa funzioni praticamente,
a partire dagli usi della vita quotidiana. Riflettere sui significati,
sulle realizzazioni ‘in situazione’ corrisponde a riconoscere
agli usi linguistici concreti - e non soltanto a quelli considerati
desiderabili - il ruolo pragmatico che effettivamente rivestono all'interno
della comunicazione.
In secondo luogo, si tratta di un approccio volto a evidenziare che
gli apprendimenti linguistici (lingua madre e lingue straniere) si potenziano
reciprocamente: confrontare sistemi diversi corrisponde a consolidare
le capacità di astrazione e di pensiero formale, sperimentando
contenuti e visioni del mondo, modi di pensare e di agire diversi da
quelli della comunità di appartenenza.
Si tratta, inoltre, di una didattica consapevole del carattere trasversale
degli apprendimenti linguistici, ovvero della funzione veicolare che
la lingua assume rispetto a qualsivoglia argomento o disciplina: a scuola
il mezzo linguistico riveste un'importanza fondamentale, in quanto ogni
passaggio di contenuto passa - esclusivamente o quasi - attraverso di
esso. Occuparsi di lingua parlando di alimentazione, riflettere su modi,
strutture e significati del linguaggio verbale anche nell'ora di Scienze
o Geografia significa svincolarsi dall'idea che l'educazione linguistica
coincida con il mero addestramento all'imitazione di norme e regole
astratte cristallizzate nei testi scolastici.
Un approccio all'educazione linguistica di questo tipo comporta indubbiamente
per l'insegnante - e non soltanto per quello di Italiano - uno sforzo
di qualità e quantità in fatto di conoscenze di ordine
teorico. Nel suo bagaglio devono entrare specifici saperi su lingue
e linguaggio (saperi socio-linguistici, psico-linguistici, storico-linguistici
e glottologici) sui quali, non per nulla, i nuovi percorsi di formazione
universitaria degli insegnanti pongono un accento particolare.
L'elemento-chiave caratterizzante un'educazione linguistica riflessiva,
tuttavia, non risiede tanto nel rimando a presupposti teorici o ideologici,
quanto nel fatto che la progettazione didattica risulta profondamente
centrata su situazioni concrete e reali, e i risultati vanno direttamente
e immediatamente ad informare tali situazioni concrete e reali che hanno
costituito il punto di partenza. La teoria, pertanto, non costituisce
un presupposto e neanche un punto di arrivo, ma trova una sua collocazione
nel momento di riflessione sulla prassi in termini di supporto per l'elaborazione
delle ipotesi didattiche, l'interpretazione dei fenomeni, l'introduzione
di cambiamenti o innovazioni, l'individuazione di soluzioni da inserire
nelle singole, concrete realtà, in un circolo virtuoso dalla
pratica alla teoria alla pratica, disponibile a una critica e costante
riflessione, ridefinizione, ridiscussione. In questa dimensione, resta
valido il principio sottostante i lavori qui presentati: de linguis
disputandum est.
Luisa Revelli
Note
(1) I significati della voce latina erano solo in parte coincidenti
con gli attuali, ragione per cui, per ragazzi che possiedano già
strumenti adeguati, l'individuazione di coincidenze e differenze dello
spazio semantico occupato dai due lessemi all'interno dei relativi campi
può costituire un punto di partenza stimolante.
(2) Il termine indoeuropeo allude a un gruppo di lingue storicamente
attestate di ceppo europeo e asiatico che hanno in comune corrispondenze
di natura morfologica, fonologica e lessicale tali da supporre la derivazione
da una lingua comune.
(3) Nel latino parlato la differenza tra vocali toniche lunghe e brevi
fu sostituita da una differenza di apertura, cioè di timbro.
Questo fenomeno condusse gradualmente alla nascita del sistema italiano,
che conosce sette vocali (i, é, è, a, ò, ó,
u). Di norma, la U si ridusse regolarmente a O chiusa.
(4) Il manifestarsi di questo tipo di produzioni, classificabili come
“errori intelligenti”, fornisce occasioni per dare ragione
e consapevolezza dei processi impliciti dell'acquisizione linguistica,
oltre che per dotare gli allievi di strumenti utili all'ampliamento
del loro serbatoio lessicale.
