




Una scuola che profuma di cibo
Ore 12: tutti a tavola!
Il mio pensiero va spesso alla cuoca della scuola del
paese dove ho prestato il mio primo anno di servizio (santa donna!) che,
verso le 10 del mattino, passava in classe a salutarci e ad annunciarci
il menù della giornata… Avevamo così ben due ore per
pregustarlo, aiutati nel piacevole compito dai profumini che provenivano
dalla cucina-refettorio adiacente alle aule.
Anche nella scuola dove insegno adesso, in città, il refettorio
è adiacente alle aule, anzi ce ne sono tre, ma di profumini neanche
l’ombra!
Fino al momento dell’apertura dei piatti contenenti i pasti preconfezionati,
il nostro refettorio odora di un anonimo profumo di pulito.
In realtà, tutto risulta un po’ anonimo: le tovagliette di
carta sui tavoli, le posate di plastica, il cibo poco saporito…
Eppure l’inserviente fa di tutto per rendere accogliente il refettorio:
disegni alle pareti, pitture a tema sui vetri delle finestre…
Sarà che usufruisco del servizio di refezione scolastica da circa
vent’anni e malgrado l’alternanza delle varie cooperative
che lo gestiscono non ho visto grandi cambiamenti, sarà che il
mio pasto da adulto è esattamente uguale per caratteristiche qualitative
a quello di un bambino di tre anni, sarà che devo dividerlo con
la mia collega di sezione (abbiamo diritto a un pasto in due), sarà…
Il verbo piacere non sopporta l’imperativo.
Allora penso che mangiare insieme, come giocare insieme, sia una grande
occasione per conoscersi e per conoscere, per sentirsi rassicurati e accolti,
per pensarsi come soggetto ricco di idee, emozioni ed esperienze.
E questo mi basta.
Arianna Montini

L’insegnante che faceva anche il cuoco
Sono ormai molti anni che non frequento più le
scuole, se non per sporadici interventi relativi all’informatica,
ma non posso fare a meno di ricordare alcuni trascorsi da maestro (chissà
perché insegnante non rende l’idea?) in quelle scuole di
paese indissolubilmente legate alle cantines, adesso Restaurants
scolaires.
Una supplenza di quindici giorni in un paesino della Coumba Freide. Il
cuoco, che era anche vigile del fuoco, messo comunale, autista dello scuolabus
(scuolabus è una parola grossa, era una vecchia Land Rover che
ancora adesso sento cigolare…), becchino, postino e chissà
cos’altro ancora, mi aveva stupito perché aveva variato ogni
giorno il menu: dall’arrosto, allo spezzatino, al bollito, agli
sgombri, ai mitici bastoncini del Capitano, di tutto era passato sulla
nostra tavola! Lo vedo ancora in una mattina d’inverno, di buon’ora,
venire verso la scuola, sotto una copiosa nevicata, portando due tacchini,
allegro e sorridente.
E che dire delle polpette di Silvana, così buone, ma così
buone che una mia collega, una volta sì e l’altra pure, faceva
indigestione; o di Ida e Maura che, ogni tanto, ci deliziavano con piatti
sfiziosi come lo zuccotto di riso foderato di prosciutto cotto.
In quelle scuole, la cucina era nello stesso edificio delle aule. A metà
mattina, già sapevi cosa avresti mangiato a mezzogiorno. L’aria
era sempre piena di profumi che lanciavano messaggi appetitosi.
Una volta, da un paesino sopra Aosta, momentaneamente isolato da un’inaspettata
e tardiva nevicata, mi hanno telefonato per chiedermi se potessi, prima
di provare a salire, passare a prendere il pane per tutta la frazione.
Nonostante la gloriosa 500 di mia madre, con tanto di catene, non riuscii
ad arrivare fino alla scuola. Ma il pane sì. Una provvidenziale
campagnola della Forestale era passata di lì e l’aveva caricato.
Sembrerà strano, ma ho supplito anche il cuoco. Insegnavo, più
di vent’anni fa, in una scuola frequentata solo da tre bambini,
ovviamente di tre classi diverse. Tra il capoluogo e la frazione c’era
un punto della strada esposto alle valanghe e quindi non si poteva, d’inverno,
rischiare di spostare i bambini (il maestro, invece…). Tutti i giorni
ricevevo “la comanda” dalla cuoca per la macelleria del fondo
valle. La cuoca, la signora Alice, che di maestrini come me ne aveva visti
tanti, aveva l’aspetto serio, quasi burbero, ma aveva un cuore grande
come una casa. Tutte le mattine “il maestro”, che, con il
sindaco, il prete e il farmacista, faceva parte delle autorità
del paese, passava dalla macelleria e portava a scuola la carne, gli affettati
e tutto quello che non si trovava nel negozietto del paese. Ma un giorno
la signora Alice si ammalò. Il sindaco, non sapendo come fare a
sostituirla, avrebbe dovuto chiudere la refezione per alcuni giorni con
il rischio che le famiglie tenessero a casa i bambini.
Forse per il senso di appartenenza ad una comunità, forse semplicemente
per l’incoscienza dei miei vent’anni, dissi di slancio: “Non
si preoccupi, se vuole faccio io da mangiare anche per i bambini, tanto
dovrei farlo per me”.
“Ma davvero lo farebbe?”
“Certo, cosa vuole che sia…”
Ed eccomi nella duplice veste di supplente cuoco e supplente maestro di
una scuola di montagna.
Certo le scuole di montagna sono un'altra cosa e non solo per la dislocazione,
ma per la loro tipicità e, ben inteso, per quella della gente che
lì vive.
Unendo le mie due nuove professionalità ricalcai il menu della
signora Alice e riuscii ad organizzare interessanti lezioni sull’acqua
che bolle, sul vapore, su come si debba condire l’insalata mettendo
prima il sale e l’aceto e solo dopo l’olio in modo da evitare
che quest’ultimo imprigioni i batteri, su che cosa sono i batteri…
Come stavano attenti i bimbi! “Lo maître” non era solo
il maestro, l’infermiere, lo psicologo, il confessore, per il più
piccolo anche il papà (come ogni tanto mi chiamava diventando tutto
rosso…), ma sapeva anche fare il cuoco!
Tutto con estrema naturalezza e semplicità. Ora, anche nelle scuole
di montagna, sono arrivati la 626, i Nas, e i dietologi: tutto a norma
di legge, ma quanto a misura d’uomo?
Pier Angelo Rosset
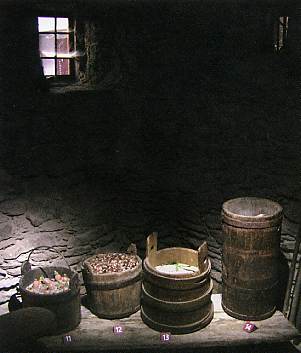
La generazione di “Camera cafè”
L’intervallo è e resterà sempre,
nell'immaginario di tutti, il momento più bello della giornata
scolastica, dalle elementari alle superiori. Non per niente si chiama
anche “ricreazione”: il suono della campanella dà finalmente
il permesso di “resettare” completamente il cervello per dedicarsi
a cose più utili della materia appena ascoltata, tipo i pettegolezzi
sulle compagne, la corsa ai bagni, i programmi per il pomeriggio o il
fondamentale problema stomaco-da-riempire.
Quando frequentavo la scuola media non mi interessava molto fare uno spuntino
a metà della mattina e anche per la maggior parte dei miei compagni
era così.
Quando sono sbarcata al liceo scientifico, saranno state le macchinette
delle lattine, le macchinette del caffè, le macchinette con le
pizzette, le focacce, il cioccolato, insomma, tutto questo ben di Dio
ha contribuito a farmi venire un certo languorino!
In effetti la giornata scolastica è piuttosto lunga, perfino se
si fa un’abbondante colazione. Verso le 11.30 (il secondo intervallo!)
la pancia comincia a emettere strani rumori. Molti ragazzi che vengono
a scuola da fuori Aosta si alzano presto al mattino e alle sei non hanno
granché voglia di mangiare, quindi è naturale che abbiano
fame dopo. Per questo c'è chi si porta la merenda da casa e chi
preferisce l'ebbrezza delle macchinette, anche con il rischio di arrivare
tardi e non trovare più la pizzetta o le schiacciatine e tornarsene
a mendicare qualcosa dai compagni.
Quest'anno, nella mia classe sta tornando di moda la frutta: c'è
chi porta una mela, chi dei mandarini o dell'uva, ma c'è anche
chi persiste col “paninazzo” pieno di qualsiasi cosa e chi
resiste senza mangiare tutte le sei ore.
Certo non è escluso che ci siano persone che non hanno fame, ma
è difficile resistere alle provocanti proposte della “macchinetta”,
la vera protagonista dell’intervallo. Tutti la prendono d'assalto
appena suona la campanella, forse proprio per quel sentore di libertà
che emana, quasi condisse le sue offerte alimentari con un sapore di indipendenza,
consentendo un’evasione personalissima dalla gabbia delle merendine
casalinghe, di routinaria confezione materna.
Molta gente preferisce bere anche solo qualcosa di caldo e dolce che ridia
energia, piuttosto che mangiare proprio qualcosa. Così davanti
alla macchinetta del caffè le code sono interminabili e si perdono
in questo modo tutti i dieci minuti dell’intervallo. È tempo
però considerato ben speso da chi torna in classe trionfante con
il bicchierino di cappuccino bollente e il bastoncino di plastica annegato
dentro. Davanti alla macchinetta si ricrea davvero un mondo a sé,
una dimensione di incontro o di ritrovo fra appartenenti a classi diverse,
un limbo in cui studenti e insegnanti convivono in maniera paritaria e,
quasi tutti, aspettano pazientemente il proprio turno. Quasi, perché
i primini tentano sempre di sgattaiolare avanti e questo dà molto
fastidio a quelli di quinta (un po' di sano nonnismo è essenziale).
Il vero dramma è quando si arriva davanti alla macchinetta e la
si trova spenta, con le sue merendine che dormono nell'ombra, inafferrabili
e indifferenti alla tua fame. In questi drammatici momenti l'unica è
farsi forza fra compagni. È in queste occasioni che il compagno
col “paninazzo” scopre di avere un mucchio di amici…
Francesca Giono Calvetto

Immaginiamo un piatto di spaghetti
Immaginiamo un invito a cena. Immaginiamo un buon piatto
di spaghetti allo scoglio pre-
parati e serviti dalla mia cara amica (disabile) nella sua casa, in cui
vive da tempo. Immaginiamo… ci riusciamo?
“A Casapiù ci vado il sabato e la domenica, faccio la
spesa, porto i soldi, li conto, si va a mangiare la pizza, andiamo in
discoteca, stiamo fuori con gli amici, ci facciamo il caffè. Mamma
e papà non vengono, papà è un bravo ragazzo, mamma
è carina però ci vuole un pochino d’aria. Mamma e
papà stanno a casa loro”.
“Il mio futuro lo immagino in un’altra casa, i miei rimangono
in via Pasquale 11, a casa loro, poi forse quando sono anziani vanno a
Santa Marinella o al centro anziani”.
“A Casa Fiordaliso aiuto a fare tante cose: cucinare, lavare i piatti
e fare la spesa e riordinare la Casa Fiordaliso”.
Esiste da pochi anni, al massimo una decina, non di più. Ma il
concetto di Progetto di Vita per le persone disabili è
diventato un forte punto di riferimento per immaginare percorsi di reale
autonomia, di inclusione nella società solidale e
di integrazione tra i servizi. Immaginare… questo è il punto:
“Come immagina suo figlio adulto?”. L’idea
di concepire un progetto per la persona disabile che la possa inserire
a tutti gli effetti e da protagonista nella società degli adulti
è, nella nostra società, cosa recente. Così recente
che discutere di adultità significa discutere work in progress,
di una condizione umana e psicologica che si sta delineando, potremmo
dire, in tempo reale sotto i nostri occhi e del cui esito noi siamo protagonisti”
(Carlo Lepri). L’immagine del disabile adulto è
ancora sovente sconosciuta all’esperienza e alla legge stessa. Soltanto
negli ultimi quindici anni la normativa, infatti, ha iniziato a considerare
possibile l’inserimento lavorativo dei disabili mentali ed intellettivi;
prima, queste persone erano considerate “incapaci di lavorare”.
Se ne deduce, quindi, che “la legge, intesa come uno dei modi che
la cultura ha di manifestarsi, considerando queste persone non idonee
al lavoro le considerava, al tempo stesso, non idonee a diventare adulte”
(Carlo Lepri).
Questo è il punto: proviamo un po’ ad immaginare
che il tempo non abbia, per una persona disabile, solo la dimensione del
presente (l’eterno bambino), ma anche quella del futuro. Cosa
immaginiamo di metterci dentro a questo futuro?
Il cibo, innanzitutto. Perché si mangia tante volte al giorno,
perché per mangiare occorre guadagnare i denari per fare la spesa,
scegliere e comperare, conservare, cucinare, apparecchiare una tavola
appropriata e sfiziosa, invitare amici o parenti per gustare i cibi, preparare
il caffè… perché mangiare bene è bello, perché
mangiando con la giusta compagnia si digeriscono anche i cavoli a merenda.
Certamente, tutto questo comporta un Progetto di Vita che consideri la
promozione, il consolidamento ed il mantenimento di abilità
di autonomia quali la cura dell’ambiente di vita, le abilità
domestiche, l’uso di denaro, orologio e telefono, la capacità
di spostarsi in modo autonomo. Tutto questo ci obbliga ad immaginare il
futuro, costruendolo sul presente. Tutto questo significa scommettere
sull’uomo e sulle sue risorse, per immaginare le persone disabili
non (soltanto) come un peso ed un dovere di presa in carico, ma (soprattutto)
come una chance in più per poter, ad esempio, gustare
insieme, nella loro casa e da loro preparato, un saporito piatto di pastasciutta
ed un bicchiere di buon vino.
Fabrizio De André lo racconta così bene nelle metafore,
nei giochi di parole e nei rimandi musicali di Ottocento (proviamo
a riascoltarla e a pensarci su un pochino, ne vale la pena): essere adulti,
secondo i valori tipici della borghesia ottocentesca, significava rispettare
ed assolvere ad alcuni compiti (uscire da scuola, iniziare a lavorare,
lasciare la famiglia di origine, selezionare il compagno o la compagna,
trovare casa, sposarsi, definire l’attività professionale,
diventare genitori, ecc.). Essere adulti oggi significa saper immaginare
un futuro per noi stessi e per la società in cui si vive.
“Mi sembra si possa dire – ci aiuta a concretizzare Carlo
Lepri - che il percorso verso una condizione di adultità segue
oggi strade e sentieri molto soggettivi. Per questo preferirei parlare
non di una, ma di “tante adultità possibili”, correlando,
per le persone disabili, queste varie adultità alla possibilità
di vivere in modo consapevole e responsabile l’accesso, anche se
parziale, ai ruoli che caratterizzano questa età della vita".
Dunque: “Buon appetito, cari amici, vi piacciono gli spaghettini
che vi ho preparato?”
Ottocento |
Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sottovento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine e cantanti su un tappeto di contanti nel cielo blu Figlia della mia famiglia Figlio bello e audace Ottocento Quanti pezzi di ricambio Figlio figlio quale intruglio ti ha perduto nel Naviglio Ein klein Pinzimonie Quanti pezzi di ricambio Fabrizio De André
|
Paolo Salomone
(I contributi di Carlo Lepri sono
tratti dal suo intervento al convegno sulla residenzialità di disabili
intellettivi “Il loro futuro ha una casa”, organizzato dall’Associazione
Italiana Persone Down a Roma, il 10-11 dicembre 2004).
Alla mensa di Moron
Ida Brunet, che per una ventina d’anni ha preparato
il pranzo ai bambini della scuola di Moron, un villaggio sulla collina
di Saint-Vincent, ci ha accolto in casa sua. Sulla parete dell’ingresso,
in bella mostra, troneggia un grande dipinto realizzato dagli alunni della
materna della sua scuola.
Ci parla con piacere della sua avventura lavorativa.
- Per caso, sono diventata cuoca a Moron. Prima vivevo e lavoravo a Torino.
Alla fine degli anni ’60, sono dovuta tornare a Moron per ragioni
di famiglia.
Un giorno, il sindaco mi ha chiesto se volessi sostituire la cuoca di
Moron che si era ammalata. Non era il mio mestiere, ma sapevo fare da
mangiare. Così ho risposto: “Ci provo!” Quando sono
entrata in quella scuola mi sono cadute le braccia. La prima cosa che
ho fatto, per diversi giorni, è stata pulire i pavimenti. La cucina
e il refettorio erano in uno stato pietoso. In cucina c’erano soltanto
una stufa a due buchi e due pentole piccole piccole. Come si poteva preparare
da mangiare a venti bambini con solo due pentole? Quell’anno ho
veramente tribolato.
Non c’erano tovaglioli, né tovaglie, né asciugamani.
Come facevano i bambini ad asciugarsi le mani? Così ho cominciato
a portare qualcosa da casa mia e a chiedere il necessario al comune.
All’inizio, qualche genitore non capiva le mie richieste e mi rimproverava
di avere pretese cittadine. “Viene da Torino. Cosa crede di fare?
Siamo sempre andati bene così!”
Con il passare degli anni, la situazione è migliorata; la mia cucina
è stata attrezzata di tutto il necessario.
Nei primi tempi, solo il pane si acquistava sul posto. Tutti i rifornimenti
provenivano da Aosta. Ricevevo sacchi enormi di una pasta integrale grigia
e lattoni di conserva da 5 kg. Conservare il contenuto di queste grosse
scatole, una volta aperte, era un vero problema.
Sempre da Aosta ci mandavano del formaggio rosso che non piaceva ai bambini.
Le razioni, non erano sempre adeguate. Come fa un bambino a stare fuori
casa tutto il giorno mangiando un po’ di pasta e un solo formaggino?
Se poi arrivava la marmellata, non arrivava il formaggio. Il pranzo era
proprio misero.
Con il passare del tempo, la situazione è migliorata; potevamo
fare direttamente la spesa in tre negozi autorizzati.
Potevo variare il tipo di pasta: farfalle, gnocchetti, spaghetti, non
sempre i soliti ditalini.
I bambini amano la varietà nel cibo. A quei tempi, qualcuno di
loro, a casa, era solito cenare a pane e latte. Cercavo sempre di preparare
qualche piatto che piacesse ai bambini, stando attenta a proporre dei
pasti equilibrati. Tutti mangiavano volentieri.
Invitavo sovente le mamme a passare dalla cucina per vedere che cosa preparavo
per i loro figli, con quanto amore cercavo di venire incontro ai loro
desideri.
Condivo la pasta in bianco con il sugo dell’arrosto: ai bambini
piaceva da morire!
Mi ricordo una bambina, che non amava l’insalata. Un giorno, ho
visto che la prendeva dal piatto e se la metteva in tasca. Non l’ho
sgridata, ma l’ho presa da parte e le ho detto: “Se non ti
piace, chiedi solo una foglia. Se metti l’insalata in tasca, ti
macchi d’unto e le maestre se ne accorgono”. Seria, seria
mi ha risposto: “Ma poi, vado ai gabinetti e la butto!”
Ogni tanto qualche bambino mi aiutava, ma mai vicino ai fornelli! Dopo
essersi lavato le manine, apparecchiava o lavava la frutta.
Con gli anni, il numero dei bambini è aumentato, sino a novanta,
ed è arrivata Maura(1) ad aiutarmi.
Insieme preparavamo da mangiare, pulivamo; trovavamo anche
il tempo di partecipare con i bambini ai lavori manuali organizzati dalla
maestra Marcella(2).
Scendevano in refettorio a disegnare, a fare la stampa. Io, poi, che ero
capace a cucire, insegnavo a qualcuno a tenere l’ago in mano.
Non riesco a tornare alla scuola di Moron, perché i ricordi di
quei tempi mi commuovono ancora. Pochi giorni fa, un signore, di una trentina
d’anni, mi ha fermata per strada e mi ha chiesto: “Ida, non
ti ricordi di me? Sono Mauro? Quand’è che mi cucini di nuovo
il risotto?”
Ida Brunet
Note
(1) Maura Truchet, aiuto cuoca. A partire dal 1992, superato il concorso,
è diventata cuoca titolare. Svolge tuttora la sua attività
nella scuola di Moron.
(2) Marcella Polese, per più di dieci anni è stata insegnante
e sorvegliante in tempo mensa nella scuola di Moron.

Professionisti della ristorazione
É stato soprattutto l’interesse per il
sociale a fare nascere, nel 1983, la Cooperativa “Noi e gli Altri”.
Cristina Monami ne è la Presidente. La cooperativa è impegnata
in molti degli ambiti del sociale, ma, in particolare, si occupa di fornire
alle scuole l’assistenza alle mense ed ai Comuni la fornitura dei
pasti caldi.
Un settore difficile perché tocca gli alunni sui quali, giustamente,
viene posta un’attenzione forte da parte dall’ente pubblico,
dei genitori, degli operatori scolastici e per i quali è necessario
prestare una continua attenzione ad aspetti delicati quali l’appetibilità
di un menù, la sua correttezza alimentare e l’equilibrio
compositivo.
Definire un menu è uno dei
punti più critici della vostra attività. Quali criteri avete
seguito per farlo? Quali esperti avete consultato?
Si tratta di un elemento talmente importante da diventare la discriminante
nel definire la gara d’appalto, ed è proprio su questa base
che noi l’abbiamo vinta. Il Comune di Aosta ha apprezzato il nostro
menu che, peraltro, era il frutto di lunghe riflessioni fatte con esperti
di alimentazione dell’età evolutiva. L’idea di fondo
era quella di rompere con la tradizione ripetitiva che proponeva ciclicamente
sempre gli stessi piatti. Abbiamo, ad esempio, introdotto la pasta con
le lenticchie, il brasato con la polenta, le penne con il sugo di tonno,
i fusilli alle melanzane, i cuori di salmone al forno ed altri. I principi
che hanno guidato gli esperti nella scelta del menu sono stati due: offrire
dei cibi ineccepibili dal punto di vista nutrizionale e un menu vario.
Il menu è piaciuto subito a noi, ai cuochi e al Comune. Qualche
sconcerto lo abbiamo rilevato da parte degli utenti. Sovente i bambini
sono abituati a mangiare continuamente le medesime cose. Un altro punto
al quale abbiamo fatto attenzione, nella sua definizione, è quello
di fare un po’ di educazione alimentare proponendo cibi molto variati
nel gusto e nel tipo in modo tale da far abituare i ragazzi a mangiare
di tutto.
La monorazione non è molto
ben accetta in genere. Perché questa scelta e come fate a far giungere
sulla tavola dei ragazzi il cibo ancora caldo?
Abbiamo una cucina in Aosta che tutte le mattine prepara cibi freschi
per le mense scolastiche. Si tratta di una cucina bella, anzi, non esito
a dirlo, la più bella di tutta la Valle e la più all’avanguardia,
un forte investimento del quale siamo estremamente soddisfatti. Il cibo
viene messo in contenitori termici che sono in grado di tenerlo caldo
per il periodo necessario ad uno spostamento di 30-40 chilometri, anche
se le scuole che serviamo non distano mai più di 5-6 chilometri
dalla cucina. Questi contenitori sono tenuti caldi tramite la corrente
elettrica e, quando arrivano nelle scuole, possono essere nuovamente attaccati
ad una presa per mantenere il cibo in temperatura fino al momento del
consumo. Questa cucina produce i pasti in piatti sigillati monodose, utilizzando
un’attrezzatura che evita qualunque intervento manuale. Servire
il cibo in piatti a perdere offre notevoli vantaggi come, ad esempio,
quello di evitare qualunque manipolazione dopo il momento della produzione.
Certo c’è il consumo della plastica, ma il vantaggio igienico
è evidente. Il problema semmai deriva dal fatto che la monorazione
comporta una concentrazione di odori e di calore che rende la presentazione
esteticamente meno efficace. D’altra parte, utilizzare dei piatti
in ceramica comporterebbe problemi sanitari ed economici quale, ad esempio,
quello di dover dotare ogni scuola di una lavastoviglie per grandi comunità.
Si sa che i genitori sono molto
esigenti riguardo all’alimentazione dei figli. Riuscite a coinvolgerli
nelle vostre scelte in modo da evitare successive proteste?
Il coinvolgimento dei genitori fa parte del progetto di educazione alimentare
che vogliamo realizzare. Ad onor del vero, gli incontri con gli esperti
di alimentazione che abbiamo organizzato durante lo scorso anno scolastico
non hanno avuto un grande riscontro di pubblico. Li abbiamo molto propagandati,
ma la partecipazione è stata bassa. Ma non demordiamo perché
riteniamo fondamentale, visto anche il gran numero di malattie prevenibili
con un’alimentazione adeguata, che ci si scambino le idee su questo
soggetto. Anche perché i valori nutrizionali non sono gli unici
parametri da tenere presenti. È altrettanto importante la conoscenza
dei gusti dei ragazzi. Le nostre scelte, in tutti i casi, sono di tipo
nutrizionale e vanno spiegate al grande pubblico altrimenti, talvolta,
possono risultare incomprensibili.
Le norme igieniche sono giustamente
molto rigide per quanto riguarda la ristorazione. Come fate a tenere sotto
controllo questo aspetto?
Le frequenti e inaspettate visite di Vigili sanitari e dei Nas, visti
gli esiti, non ci preoccupano affatto anzi ci consentono di confermare
la qualità del nostro lavoro. è giusto che ci siano e sono
una garanzia anche per noi, attestano che il nostro lavoro è svolto
in modo serio, scrupoloso e igienicamente ineccepibile. Siamo fieri dei
complimenti che ci sono stati fatti per la pulizia, la conduzione delle
cucine e la professionalità del nostro personale.
É cambiato notevolmente
il profilo del personale addetto alle mense e sono cambiate anche le attività
richieste e proposte. Cosa fate per il dopo pasto?
Il personale animativo ha un progetto di lavoro. Noi abbiamo due obiettivi:
favorire lo stacco tra l’attività scolastica del mattino
e quella del pomeriggio e ridurre, nel momento della refezione, la pressione
alla quale gli alunni sono sottoposti nell’attività scolastica.
Si tratta di presentare agli alunni proposte morbide e non impositive
per concedere loro una vera e propria “tregua”. Per fare questo
scegliamo persone che abbiano almeno conseguito un diploma, che dimostrino
buona capacità di comunicazione e meglio ancora se hanno figli...
Abbiamo anche cura che si tratti di persone giovani, ma affiancate da
persone più mature. Così facendo, possiamo offrire una vasta
gamma di atteggiamenti e modalità di relazione a coloro che usufruiscono
della refezione. Un altro obiettivo che ci proponiamo e che chiediamo
al personale di realizzare è quello di rendere le stanze più
gradevoli. Spesso, durante il dopo pranzo, vengono effettuati lavori di
ottima qualità. Abbiamo anche dotato ogni gruppo di cancelleria
varia, giochi da tavola, attrezzi e gli immancabili palloni di spugna
per permettere ai maschi e alle femmine di soddisfare questo desiderio.
Non crediamo sia possibile utilizzare solo giochi di società perché
si devono tenere in considerazione sia i bambini più vivaci sia
quelli più tranquilli.
Inoltre, all’interno della nostra cooperativa, siamo in grado di
provvedere una rete di professionalità specifiche per gli alunni
diversamente abili. In queste situazioni, prima di prendere in carico
il bambino con i suoi problemi e le sue difficoltà, ci confrontiamo
con l’équipe territoriale, con le insegnanti che lo hanno
in classe, con il bambino stesso e la sua famiglia.
Refettori rumorosi e spazi per
il dopo pranzo disagevoli. Le scuole difficilmente sono state costruite
tenendo presente che ci sarà una mensa. Come si risolve questo
problema?
Quando per il dopo pasto siamo costretti ad utilizzare i corridoi della
scuola, come gestire questo spazio diventa un problema. La maggior parte
delle volte le scuole non dispongono di altro, allora le attività
possono divenire demotivanti e anche l’attività educativa
rischia di non raggiungere lo scopo che si prefigge.
Circa la rumorosità dei locali adibiti alla refezione, riteniamo
sia impossibile convincere i bambini a non parlare a tavola. Non solo,
non siamo neppure convinti che sia corretto. Il momento del pasto è
spesso quello in cui il bambino ha uno spazio per raccontare, per confrontarsi
con gli adulti e i compagni, per confrontare le proprie esperienze extra
scolastiche. è il momento in cui può parlare con un adulto
di argomenti non scolastici. Proprio in questi momenti i bambini raccontano
molte cose della propria vita. È in questo spazio che si mostrano
le diverse personalità. E questo è possibile perché
si tratta di un momento particolare della giornata, un momento in cui
si è rilassati. Certo, se le pareti e il soffitto fossero dotati
di pannelli fonoassorbenti la vivibilità sarebbe tutt’altra.
È facile immaginare che
è necessario un lavoro di équipe per organizzare una struttura
così complessa.
Abbiamo, all’interno del nostro staff, un laureato che coordina
il servizio. La responsabilità della gestione del personale, la
fornitura dei pasti e le attività didattiche ricadono sotto la
sua diretta responsabilità. Nella nostra équipe sono presenti
anche due psicologi che rappresentano un chiaro punto di riferimento per
le problematiche di tipo psicologico e didattico. Sono previsti incontri
periodici per analizzare quanto accade. Una psicologa è attiva
nel nostro staff a tempo pieno e funge anche da coordinatrice delle attività
animative, mentre l’altra collabora con noi fornendo una supervisione
generale di tipo psicologico.
Uno dei nostri punti di forza, in questo ambito, sono le riunioni settimanali
che ci permettono di favorire il passaggio di competenze, esperienze e
di conoscenze assumendole da tutti le attività della cooperativa.
I vostri assistenti rappresentano
la continuità rispetto al docente.
Si tratta sempre di un incontro di personalità e di professionalità
diverse. I due ruoli non coincidono, ma si agisce comunque su bambini.
Il dialogo tra insegnanti e assistenti è spesso costruttivo. Certamente
ci sono delle situazioni in cui ci sono stati problemi di comunicazione,
ma, nella maggior parte dei casi, soprattutto là dove sussistono
delle difficoltà, si è cercato di superarle con la buona
volontà da parte di entrambi e quasi sempre ci si è riusciti.
Intervista a Cristina Monami

