




Lo Statuto: un'occasione di partecipazione?
Ormai da
alcuni anni, in particolare con l’introduzione dello Statuto degli
studenti e delle studentesse (d.P.R. 249/98), si parla spesso del ruolo
dello studente, dei suoi diritti e dei suoi doveri.
Questi argomenti, è inutile negarlo, creano un certo fastidio a docenti
e dirigenti scolastici e sono sottovalutati da molti studenti. Perché
un ragazzo dovrebbe avere il diritto di esprimersi e in un qualche modo
di poter influenzare scelte di competenza dei docenti, relative a “programmazione,
definizione degli obiettivi didattici, organizzazione della scuola, criteri
valutazione, scelta dei libri di testo e materiale didattico”? In
sostanza, perché lo studente dovrebbe modificare il suo ruolo, da passivo
ad attivo, per contribuire alla costruzione della scuola?
Frasi tipiche da “sala insegnanti” sono ad esempio: “Ormai
abbiamo completamente le mani legate”, “Perché nessuno sta più
nel suo ruolo e gli alunni non fanno gli alunni e noi insegnanti non possiamo
fare gli insegnanti?”
In effetti, la riforma della scuola e in particolare l’autonomia
scolastica e lo Statuto hanno smosso profondamente un ambiente per troppi
anni statico.
E’ quindi ovvio, direi perfino legittimo, che ci si ponga queste
domande.
È naturale che di fronte ad un radicale cambiamento culturale, si possano
incontrare resistenze, più o meno forti. Importante è però non cercare
di imporre le novità, lasciando indietro e emarginando chi non ne ha ancora
percepito l’importanza, ma impegnarsi per arrivare ad una coscienza
comune dell’importanza e della ineluttabilità del cambiamento.
La risposta a questi interrogativi sta nella concezione che si ha della
scuola.
Si può pensare alla scuola semplicemente come un ente erogatore di un
servizio.
In questo caso è chiaro che lo studente e le famiglie si devono limitare
a fruire dei servizi messi loro a disposizione, senza aver la possibilità
di intervenire nel procedimento di formazione del “prodotto”
insegnamento.
Al contrario lo Statuto ha introdotto il concetto di scuola come “comunità”.
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona
in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e
il recupero delle situazioni di svantaggio...”.
Risiede proprio nel concetto di comunità la grande novità. Dalla definizione
data dallo Statuto può emergere una nuova idea di scuola che rende necessario
un cambiamento di ruolo alle componenti scolastiche. Il concetto di comunità
esprime l’idea di un gruppo di persone che convive per il raggiungimento
di un obiettivo comune.
Chi fa parte della comunità non può che essere cittadino della comunità
stessa, il che implica un’assunzione di responsabilità e di doveri
ma anche un’acquisizione di diritti. Gli studenti che appartengono,
quindi, ad una comunità, ispirata a valori democratici, possono, attraverso
un percorso culturale e sociale personalizzato, costruire la propria identità.
Una scuola non per tutti gli studenti quindi ma per ognuno di essi. Lo
studente non può essere escluso dal processo di costruzione di una comunità,
che per forza di cose, per essere sentita come propria, deve essere vissuta
da co-protagonista. La partecipazione attiva degli studenti non dovrebbe
essere vista come una concessione, dunque, ma come una caratteristica
naturale ed intrinseca della struttura e dell’organizzazione scolastica.
Troppo spesso i problemi della scuola sono stati invece visti quasi esclusivamente
dal punto di vista degli insegnanti e delle loro (pur giuste) rivendicazioni
sindacali.
Solo se si accetta un’idea di scuola come comunità si potrà garantire
una reale formazione alla cittadinanza.
Si potrà, cioè, trasmettere valori democratici invogliando gli studenti
a seguire un percorso formativo in vista di una effettiva realizzazione
personale, non con atteggiamenti personalistici ma collaborativi e rispettosi
del bene comune. Non in un quadro di scontro tra le componenti scolastiche
ma di rispettiva legittimazione, pur nella diversità dei ruoli.
Il triennio 97/99 è stato un periodo di trasformazioni. Oltre alle norme
sull’autonomia scolastica e sulla partecipazione studentesca, altri
tasselli hanno dato vita ad un mosaico riformistico complesso, in parte
bloccato dall’abrogazione dalla legge costitutiva della riforma dei
cicli. Nelle novità introdotte dal Ministro Luigi Berlinguer: l’innalzamento dell’obbligo scolastico,
la definizione dell’obbligo formativo e il nuovo esame di Stato.
È all’interno di questo panorama che si è inserita la mia vita di
studente. Mi sono calato pienamente in questo contesto di cambiamento,
cercando di sfruttare al massimo le possibilità che mi venivano concesse.
Sono stato eletto due volte rappresentante d’istituto al Liceo Scientifico
di Aosta e una volta rappresentante alla Consulta studentesca, dove ho
ricoperto il ruolo di vice presidente. L’anno successivo ho continuato
la collaborazione con la Consulta impegnandomi nell’effettuare un
sondaggio, a studenti e insegnanti delle scuole superiori, relativo alla
vita all’interno del mondo scolastico e in particolare alla conoscenza
e all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti d’istituto.
Ritengo di essere stato fortunato ad aver vissuto tale periodo, perché
mi ha fatto maturare permettendomi di esercitare il diritto ad una cittadinanza
attiva. Alcuni miei professori mi hanno incoraggiato e sostenuto nei momenti
più delicati.
Ho cercato di trasmettere la passione per la politica (intesa come impegno
nei confronti della società) ai miei coetanei, spronandoli a mantenere
alto il livello d’impegno nonostante le grandi difficoltà e gli scarsi
risultati.
Un impegno, si voleva, non solo istituzionale ma anche associativo. La
risposta più comune all’invito al coinvolgimento era che: tanto,
nonostante tutti gli sforzi, nulla poteva cambiare. È quello che detiene
il “potere” che ha il coltello dalla parte del manico.
Sicuramente questa risposta può essere considerata un alibi per nascondere
indifferenza e mancanza di volontà di mettersi in gioco. Ma tanti ragazzi,
anche impegnati in altri campi della loro vita sociale, erano sinceri.
Ritengo che finché non ci sarà consapevolezza delle potenzialità dei mezzi
che ognuno di noi ha a disposizione, difficilmente qualcosa potrà cambiare.
Ciò che manca realmente
a scuola è una vera educazione alla legalità: intesa come formazione alla cittadinanza.
È fondamentale cercare di fare comprendere il senso delle regole, che
sono alla base della tenuta di un sistema democratico. Spesso si ha una
visione distorta del senso delle regole, che non sono più il mezzo per
una giusta e pacifica convivenza delle parti, ma uno strumento nelle mani
di chi le conosce meglio e di chi le può gestire da una posizione di maggior
potere.
E quanti sono i casi in cui le distorsioni delle regole avvengono per
mano di chi dovrebbe dare il buon esempio (dirigenti, insegnanti, amministratori,
datori di lavoro, ecc.). E come si può pretendere poi che i ragazzi crescano
con un’idea positiva del valore delle regole che invece vedono infrangere?
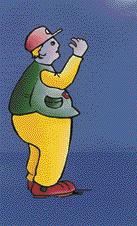
Solo grazie
al lavoro equilibrato di insegnanti e dirigenti, alla loro passione e
al loro impegno, che costituiscono un modello per i ragazzi, ciò potrà
avvenire. L’impatto con il sistema scuola è determinante per l’acquisizione
del concetto di legalità. Non bisogna infatti dimenticare che la scuola
è il primo esempio di istituzione nel quale il ragazzo è inserito. Se
si sentirà in una posizione di impotenza, in cui vince sempre chi detiene
il potere, crescerà con questa idea di Stato e di istituzione.
È per questo che ritengo fondamentale che l’educazione alla legalità
sia al centro dell’insegnamento e sia un obiettivo prioritario della
scuola.
Ho trovato interessanti altre risposte: nella pressoché totalità dei questionari
sottoposti a quasi duemila studenti delle scuole superiori, alla domanda:
“Sei interessato a diventare rappresentante
d’istituto?”
Spaventa la responsabilità di assumersi un incarico considerato importante,
impegnativo e fuori dalla portata delle possibilità di ciascuno.
Una buona parte degli intervistati ritiene infatti di non essere in grado
di ricoprire tale incarico. Tutto ciò dovrebbe fare riflettere, e molto.
È significativo che la maggioranza dei ragazzi nutra scarsa considerazione
delle proprie potenzialità, che sia una conseguenza di come è strutturata
la scuola? Compito della scuola è occuparsi della formazione dei ragazzi.
Se la stragrande maggioranza degli studenti di scuola superiore si sente
così insicura, la scuola sicuramente non ha contribuito a fondare la loro
autostima.
Educazione alla legalità vuol anche dire fare acquisire coscienza delle proprie potenzialità. Mi ha stupito verificare che alcuni principi che
ritenevo scontati, sono stati introdotti nella vita scolastica solo con
lo statuto del 1998.
Faccio qualche esempio. Lo Statuto afferma un principio che sembra pacifico:
la responsabilità è personale. Ma quante volte accade ancora
oggi che insegnanti utilizzino la nota di classe o obblighino un’intera
classe a risarcire un danno se il responsabile rimane ignoto?
La sanzione deve avere finalità educativa, tendere al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti, deve essere
ispirata alla riparazione del danno e deve essere sempre offerta la possibilità
all’alunno di convertire la sanzione in attività a favore della comunità
scolastica. Non è con l’autoritarismo che si insegna, ma con
l’autorevolezza.
Scrive Berlinguer: “La società e i giovani si aspettano dalla
scuola un impianto educativo che conservi rigore e autorevolezza, regole
e principi, ma colga insieme la nuova dimensione della libertà, il crollo
del vecchio principio di autorità, dell’ipse dixit. Una delle cose
che meno comprende [una certa parte della società], e che più la fa soffrire,
è l’esplosione della libertà come il più corposo e irrefrenabile
dei bisogni nuovi, giovani, di oggi. E non la comprende perché non ha
assorbito il concetto che la libertà anche per i docenti coincide con
impegno e responsabilità e non è solo ordinare e disporre. E quindi costa
di più, a tutti noi.”
Roberto Chenal
| Il questionario agli studenti | ||
| SI % | NO % | |
| Sei a conoscenza dell’esistenza dello Statuto degli studenti e delle studentesse? | 46 | 54 |
| Se sì, l’hai mai letto? | 5 | 95 |
| Sei a conoscenza dell’esistenza del regolamento d’istituto? | 60 | 40 |
| Se sì, l’hai mai letto? | 31 | 69 |
| Ritieni di essere trattato con rispetto dagli insegnanti? | 78 | 22 |
| Ritieni che gli insegnanti ti riescano a trasmettere messaggi culturali ed educativi adeguati? | 63 | 37 |
| Ti candideresti a rappresentante d’istituto? | 10 | 90 |
