




Parole dette, parole lette
A scuola, ore 7.55, sala insegnanti, atmosfera da risveglio, frasi sospese, comunicazioni essenziali tra colleghi mattutini, regolarmente conclusi con un ne dobbiamo parlare poi, ne parliamo, ne riparliamo... Di solito, non se ne riparla.
Ore 15.00, riunione del consiglio di classe.
Parole ufficiali. Sorge una domanda o una proposta, un progetto o un quesito;
per lo più si conclude con dobbiamo allargare il discorso agli altri
componenti; ne dobbiamo parlare in collegio docenti.
Intervalli, lungo le scale: fervore di scambi di informazioni precise,
“di servizio”, immediatamente operative: allora, in questa
classe, vai tu al 3° modulo... oppure ti ho messo nel cassetto
le fotocopie del progetto... Arrivati in sala insegnanti, il ventaglio
di scambi si allarga a tal punto da perdere ogni possibilità di conclusione:
appena iniziato un guarda questa prova per la terza, arriva l’ottimo
collega desideroso di far convergere gli sforzi ho iniziato a trattare
l’argomento sul quale ci siamo messi d’accordo (ma diventa arduo
ricordarsi quale), interviene, scusandosi, il collega pressato dalla necessità
scusa è un’emergenza, ti va bene per domattina? mentre la bidella,
educatamente ma insistentemente, tende l’ultima circolare da firmare
urgentemente; questo nella semplice veste di insegnante, se poi sei coordinatore
di classe, referente, o collaboratore del preside, gli interventi si moltiplicano
fino a frantumarsi nel nulla: non colleghi più, non reagisci più.
Qualche momento di tregua c’è e va a finire che, commossi dalla possibilità
di parlare veramente, ci si lasci sfuggire l’occasione, si parla
di altro, di sé, di noi, di lui e di lei, correndo il rischio di concludere
con ti dovevo dire una cosa, ma non me la ricordo...
I momenti migliori, naturalmente, sono davanti alla macchina del caffè;
i peggiori, regolarmente, nelle riunioni programmate per parlare di (alunni,
orari, programmi, prove, recuperi, obiettivi...), da dove si esce con
queste parole non abbiamo parlato di (a scelta, una delle voci precedenti).
A date regolari, si svolgono i “colloqui” con i genitori: si
parla, sì; tra la seduta psicanalitica e l’ingiunzione penale, le
sfumature sono tante, ma forse il vero colloquio non si svolge qui, dove
genitore e insegnante si fronteggiano, bensì fuori, durante le estenuanti
attese, nelle parole incrociate di genitori, negli scambi di impressioni,
giudizi, apprezzamenti e disperazioni collettive che riecheggiano lungo
i corridoi, da noi non udite.
Ed il luogo che non c’è... talvolta, ci mandiamo vicendevolmente
mail, sentendoci meravigliosamente virtuali ma anche, sempre, sfasati:
peccato, da un mese non ho aperto la posta elettronica, quando scadeva
questo concorso?
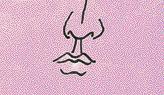
E la classe?
E’ un luogo di parola?
Nostra sicuramente, ma loro? Le parole che circolano sono quelle risposte
che otteniamo dopo qualche insistenza o non piuttosto tutte le altre?
quelle che si sussurrano, non sempre discretamente, quelle che si scrivono
su bigliettini, banchi, libri di scuola da cancellare poi, malvolentieri;
dovremmo chiederlo a loro.
E’ una loro risposta quella data durante le serate organizzate dall’Envers
Teatro nella biblioteca comunale di Viale Europa? Forse sì. Proviamo a
leggerla con una presa di parola dei ragazzi, fuori dalla classe, in un
luogo diverso.
Ad anno scolastico da poco iniziato viene proposto dagli attori dell’Envers
Teatro,
nelle varie scuole superiori, un concorso:
“10 pagine per
10 musiche”, che invita i ragazzi a partecipare ad una
singolare gara letteraria a colpi di pagine letterarie.
Il gioco è semplice: si tratta, per ogni gruppo scolastico, di scegliere
liberamente alcuni testi, accompagnati da brani musicali, e rispondendo
alla domanda: “Con che libro, con che musica affascini il tuo cuore?”
Si fa appello unicamente al gusto, alla sensibilità, alla spontaneità
ed al richiamo del gioco a più squadre. Infatti, spetterà al pubblico
(compagni, parenti, insegnanti...) eleggere le “pagine più belle”
tra quelle che si confronteranno nelle tre serate previste per questo
piccolo torneo. Gli organizzatori non hanno idea di quale possa essere
la risposta; ma questa, ben presto, arriva.
Durante quattro serate nel mese di dicembre vediamo riempirsi la sala
della biblioteca di studenti (nove gruppi di ragazzi dai 14 ai 18 anni
provenienti da diverse scuole), piuttosto allegramente concorrenti - registi
per qualche minuto della messa in scena del “loro” testo.
Pronti a difendere con qualche parola di introduzione le proprie proposte,
dal laconico e simpatico “mi è piaciuto molto” alla più articolata
considerazione sul filo conduttore tra autori, testi, temi, musiche, gli
stessi studenti sono apparsi talvolta stupiti dal risultato della lettura:
la risonanza delle parole attraverso la modulazione della voce del lettore,
i silenzi, l’avvicendarsi di voce maschile e femminile e, soprattutto,
la musica. A loro così vicina, essa incornicia il testo, talvolta introduzione
ad una atmosfera, illustrazione o sottolineatura di un passaggio, quasi
sempre conclusione necessaria.
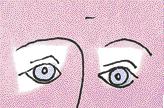
I piccoli
gruppi di ragazzi partecipanti sono sostenuti dal pubblico: i loro compagni,
alcuni genitori ed insegnanti, tutti presenti per decidere, votando per
alzata di mano, quali siano “le pagine più belle”. Se regna
un certo spirito di squadra che indirizza i voti verso la propria scuola,
alcune pagine sono irresistibili e vengono votate da tutti, indistintamente
(è così per le pagine di Primo Levi, di Martin Luther King, di Benigni).
Durante quelle serate si sono sentite parole, scritte, lette, scelte,
recitate da professionisti, interpretate. Ha avuto luogo una reazione
(processo), apparentemente non dissimile da quella che avviene a scuola
- una domanda viene posta, una risposta viene data, forse - ma questa
è diversa: qui non vi è stata la semplice domanda, ma la richiesta di
scelta, non la valutazione, ma “il premio” (buoni-libri o CD),
non l’esposizione personale ma la voce degli attori, non l’insegnante
ma il pubblico, non la scuola, puro intermediario, ma uno spazio scenico,
dove le parole da loro proposte, scorporate dal testo, dall’aula,
“scombinate” grazie agli accostamenti musicali, risuonano.
Chi sono, dunque, gli attori che i giovani hanno scelto come loro porta-parole?
Certo, prima di rispondere, va ricordato che la “regola del gioco”
imponeva una lunghezza massima, una pagina appunto, che indirizzasse naturalmente
verso il testo di senso compiuto in spazio breve, un poco particolare:
poesia, fiaba, prosa poetica, canzone.
Comunque, osserviamo il risultato finale delle scelte, le quarantacinque
pagine
recitate. Possiamo forse trarne qualche considerazione.
Vi sono sicuramente diversi modi di leggere le loro scelte, ma qualunque
esse siano, risalta il loro largo respiro: da Omero a Mishima, senza paura,
non si esita di fronte a Shakespeare, Manzoni è presente e si accosta
alla Smemoranda come a Jack Frusciante.
Quali parole
dunque? A tratti prevalgono quelle del sogno, del fantasticare, vicine all’infanzia
nel desiderio di volare (Storia di una gabbianella di Luis Sepulveda,
Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, Harry Potter
di Joanne K. Bowling). Altrove dominano parole di sfida (Il Corsaro nero di Emilio Salgari, o Fluo,
Storie di giovani a Riccione di Isabella Santacroce), sognanti ancora.
Addirittura, altre non sono lontane dal ritmo vocale della fiaba, quella saggia
(L’albero di Shel Silverstein, L’Alchimista
di Paulo Coelho, Le Petit Prince di Antoine de Saint-Exupéry,
Il delfino di Sergio Bambaren), consolatoria o violentemente liberatoria (La storia infinita e Momo di
Michael Ende). A noi può sembrare un mondo già conosciuto, tra l’innocente
e l’innocuo.
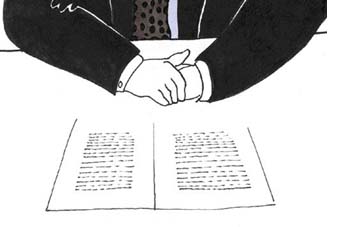
Ma non si
ferma lì, questo mondo, ora si vela di note inquietanti quando vi viene
introdotto il mostro (Frankenstein di Mary W. Shelley) o meglio,
le parole di disgusto del creatore del mostro verso la sua creatura, quasi
all’opposto delle amare parole della marionetta che anela ad essere
uomo (Se ne va un genio di Gabriel Garcia Marquez) o, ancor di
più, definitive, per quanto riguarda questo gioco del creatore e del creato,
le parole di Icaro che ripudia, nel suo volo, il suo esser uomo (Sole
e acciaio di Yukio Mishima).
Se questo è un uomo, parole del titolo così spesso presente nelle
letture dei ragazzi, degli adulti: non è più il mondo fantasioso che ora
appare bensì, duro, quello della realtà, da quella dei testimoni (Primo
Levi, Anna Franck), quella dei profeti e dei poeti (I have a dream
di Martin Luther King, Explico algunas cosas di Pablo Neruda),
a quella più intima (Lettera ad un bambino mai nato di Oriana
Fallaci, o un brano dell’Antologia di Spoon River di Edgar
Lee Masters).
Non vi è qui concessione, le pagine scelte sono forti, le parole dirette:
bombardamenti, reticolato elettrico, sangue dei bambini.
Quando i ragazzi decidono di parlar chiaro, le pagine diventano violente,
trasgressive, volutamente martellanti, complice la notevole lettura sincopata
di Valeriano Gialli su base di Miles Davis, (Castelli di rabbia
di Alessandro Baricco, O bianco o nero dalla “Smemoranda”);
qualche cosa di furioso si fa strada attraverso le invettive. Questo furore
intenso si stempera in un leggero disincanto nelle poche righe riferite
alla scuola, sarcastiche, come si deve (Jack Frusciante è uscito dal
gruppo di Enrico Brizzi).
Può sembrare strano, di amore se ne parla abbastanza poco,
ma in modi struggenti, non lievi, disperati (Romeo e Giulietta
di William Shakespeare, La donna sciocca di Lope de Vega, Eugénie
Grandet di Honoré de Balzac, Poesie d’amore di Pablo
Neruda).
Parole serissime, in tutte e quattro le serate, con un solo passaggio comico,
di grande successo: E l’alluce fu di Roberto Benigni, isolato
tra rabbie, guerre e disperazioni d’amore.
Tra le ultime parole previste nel Dizionario definitivo (George Orwell,
1984) rigorose definizioni delle poche idee ancora in circolazione, sterili
contenitori degli ultimi pensieri possibili e le parole che si levano
come esordio necessario dal silenzio primordiale (L’altra faccia
del silenzio, Margaret Mahy), ricordiamo infine ciò che forse, più
di ogni testo, esprimeva veramente “le parole dei ragazzi”:
la musica, suoni, canzoni, arie, ritmi, contrasti voluti tra opera e pagina
moderna, poesia ineffabile e fragore di percussioni.
Barbara Wahl
